Michael Tomasello è condirettore del Max Plank Institute di Lipsia per l’Antropologia evolutiva. Note bio-bibliografiche (qui), una lunga intervista (51.13) qui . Il libro: Unicamente umani. Storia naturale del pensiero; Il Mulino, Bologna, 2014.
 Il libro di Micheal Tomasello, sostiene una tesi: a) ciò che ci fa propriamente “umani”, specie a parte del mondo animale, anche di quello delle grandi scimmie antropomorfe, è la nostra peculiare forma di pensiero; b) il pensiero umano ha una sua precipua forma scolpita dal processo di adattamento continuato: la forma che serve a farci cooperare tra consimili; c) ergo, l’essenza adattiva umana è la tendenza alla cooperazione[1]. Dalla Prefazione: “gli esseri umani non solo comprendono gli altri come agenti intenzionali, ma si uniscono a loro anche nelle più diverse forme di intenzionalità condivisa, dalla soluzione collaborativa di problemi alla creazione di complesse istituzioni culturali” (7-8). I pilastri funzionale di questa mente tendente alla cooperazione cioè alla condivisione e coordinamento dell’intenzionalità sono la rappresentazione di tipo cognitivo, la capacità inferenziale, l’automonitoraggio ricorsivo. La costruzione di questo sistema mentale distintivo della specie, che poi fu anche ciò che ci distinse dal ceppo evolutivo delle grandi scimmie, ebbe una prima definizione iniziale e poi una seconda che ampliò e precisò ulteriormente questa forma peculiare. L’Autore quindi ritiene esser questa la nostra specificità: interrelarci per formare sistemi umani. La nostra peculiare strategia adattiva, che visti i risultati comprativi con le altre specie e considerato che di per sé siamo animali abbastanza disarmati e fisicamente relativamente performanti e abbastanza aspecifici è stata di vero successo, è stata costruire “sistemi adattivi” (gruppi, società) nei quali infilarci tutti assieme perché, semplicemente, l’unione fa la forza.
Il libro di Micheal Tomasello, sostiene una tesi: a) ciò che ci fa propriamente “umani”, specie a parte del mondo animale, anche di quello delle grandi scimmie antropomorfe, è la nostra peculiare forma di pensiero; b) il pensiero umano ha una sua precipua forma scolpita dal processo di adattamento continuato: la forma che serve a farci cooperare tra consimili; c) ergo, l’essenza adattiva umana è la tendenza alla cooperazione[1]. Dalla Prefazione: “gli esseri umani non solo comprendono gli altri come agenti intenzionali, ma si uniscono a loro anche nelle più diverse forme di intenzionalità condivisa, dalla soluzione collaborativa di problemi alla creazione di complesse istituzioni culturali” (7-8). I pilastri funzionale di questa mente tendente alla cooperazione cioè alla condivisione e coordinamento dell’intenzionalità sono la rappresentazione di tipo cognitivo, la capacità inferenziale, l’automonitoraggio ricorsivo. La costruzione di questo sistema mentale distintivo della specie, che poi fu anche ciò che ci distinse dal ceppo evolutivo delle grandi scimmie, ebbe una prima definizione iniziale e poi una seconda che ampliò e precisò ulteriormente questa forma peculiare. L’Autore quindi ritiene esser questa la nostra specificità: interrelarci per formare sistemi umani. La nostra peculiare strategia adattiva, che visti i risultati comprativi con le altre specie e considerato che di per sé siamo animali abbastanza disarmati e fisicamente relativamente performanti e abbastanza aspecifici è stata di vero successo, è stata costruire “sistemi adattivi” (gruppi, società) nei quali infilarci tutti assieme perché, semplicemente, l’unione fa la forza.
Il testo di Tomasello è di tipo scientifico e quindi è corredato di richiami alla vasta letteratura specifica sull’antropologia evolutiva, la linguistica, la primatologia, la psicologia evolutiva ma il primo capitolo, inizia con una batteria di più ampi riferimenti culturali, dato che l’Autore mostra di sapere che ogni ipotesi quale poi cercheremo di suffragare in vari modi, empirici, logici e teorici, nasce già carica di teoria. I riferimenti di questa epistemologia a priori, per Tomasello, sono: Hegel, Peirce, Vygotskij, Bachtin, Mead, in parte Wittgentstein e forse il più rilevante per lui, visto che specificamente egli si occupa anche di psicologia dello sviluppo, Piaget che apre in esergo l’intero studio. Tale costellazione, si trova nella nostra galassia concettuale, la galassia del pensiero della complessità. Il tutto, porterà Tomasello, come già lo ha portato nello sviluppo di tutti i suoi studi, ricerche, libri che ne riportano gli esiti, a sostenere un paradigma tripartito fatto di accentuazione del nostro specifico culturale su quello naturale, ontogenetico su quello filogenetico, cooperativo-sociale su quello competitivo-individuale. Su una base naturale, filogenetica, individual-competitiva che ereditiamo dal tronco dell’albero della famiglia delle antropomorfe, noi siamo quel ramo che dandoci una lunga ontogenesi in cui agisce cultura, società e trasmissione dei codici, ha sovraimposto a gli istinti individuali competitivi, quelli cooperativi sociali. Questo ramo, ha due snodi che l’Autore ci porta, con dovizia di esempi, specifiche e comparazioni, a mettere a fuoco.
vari modi, empirici, logici e teorici, nasce già carica di teoria. I riferimenti di questa epistemologia a priori, per Tomasello, sono: Hegel, Peirce, Vygotskij, Bachtin, Mead, in parte Wittgentstein e forse il più rilevante per lui, visto che specificamente egli si occupa anche di psicologia dello sviluppo, Piaget che apre in esergo l’intero studio. Tale costellazione, si trova nella nostra galassia concettuale, la galassia del pensiero della complessità. Il tutto, porterà Tomasello, come già lo ha portato nello sviluppo di tutti i suoi studi, ricerche, libri che ne riportano gli esiti, a sostenere un paradigma tripartito fatto di accentuazione del nostro specifico culturale su quello naturale, ontogenetico su quello filogenetico, cooperativo-sociale su quello competitivo-individuale. Su una base naturale, filogenetica, individual-competitiva che ereditiamo dal tronco dell’albero della famiglia delle antropomorfe, noi siamo quel ramo che dandoci una lunga ontogenesi in cui agisce cultura, società e trasmissione dei codici, ha sovraimposto a gli istinti individuali competitivi, quelli cooperativi sociali. Questo ramo, ha due snodi che l’Autore ci porta, con dovizia di esempi, specifiche e comparazioni, a mettere a fuoco.
Il discorso di Tomasello, inquadra più o meno questa sequenza: a) alcune forme della nostra mente sono ereditate dal comune ceppo delle scimmie antropomorfe; b) il nostro ramo, il ramo Homo, sembra aver comportato nuove forme che hanno permesso intenzionalità condivisa; c) questo ramo che già ha qualcosa di diverso dal tronco originario, qualcosa che già si mostra nei bambini prelinguistici e non è quindi frutto di apprendimento culturale, ha poi un altro snodo che ci ha portato all’intenzionalità collettiva (Homo sapiens sapiens). In termini di sistemi, potremmo dire che la prima forma di intenzionalità è quella che forma il sistema laddove le parti si scambiano intenzionalità attraverso le reciproche interrelazioni, la seconda forma fa agire il sistema del noi come un soggetto unitario e nel tempo, produce sistemi culturali. Il primo sistema nacque per collaborare alla scala di piccoli gruppi per la ricerca del cibo e si avvalse dello scambio comunicativo a base gestuale e mimica che implicano già una mente capace di fare e ricevere rappresentazioni prospettiche (da più punti di vista) e simboliche, fare  inferenze socialmente ricorsive (il ricevente cercava di pensare “cosa mi sta dicendo?”), automonitoraggio in seconda persona (l’emittente doveva preliminarmente simulare nella sua mente cosa il ricevente avrebbe potuto capire). Tali forme mentali comuni, si può dire cementassero una logica comune. Questa è l’intenzionalità congiunta, il secondo sistema, l’intenzionalità condivisa, si è sviluppato in seguito alla necessità di coordinamento di gruppi più grandi, eventualmente tra loro in competizione (ma non so se “competizione” sia il termine più appropriato). Qui il terreno comune non era più solo dato da forme mentali comuni ma costruito da una “cultura” fatta di convenzioni, norme ed istituzioni, tessuta da interrelazioni pienamente linguistiche, la logica mentale comune diventava comune razionalità, il soggettivismo prospettico (basato su diversi punti di vista) diventava oggettivo (da tutti i punti di vista). Le rappresentazioni diventavano quindi anche convenzionali ed oggettive, le inferenze divennero anche autoriflessive e poggiate su “ragioni”, l’autoregolazione si apriva alle norme di razionalità della cultura d’appartenenza. Lo sviluppo di tutto questo secondo sistema, secondo Tomasello, non ha basi biologiche ma culturali, è cioè “appreso” nell’ontogenesi.
inferenze socialmente ricorsive (il ricevente cercava di pensare “cosa mi sta dicendo?”), automonitoraggio in seconda persona (l’emittente doveva preliminarmente simulare nella sua mente cosa il ricevente avrebbe potuto capire). Tali forme mentali comuni, si può dire cementassero una logica comune. Questa è l’intenzionalità congiunta, il secondo sistema, l’intenzionalità condivisa, si è sviluppato in seguito alla necessità di coordinamento di gruppi più grandi, eventualmente tra loro in competizione (ma non so se “competizione” sia il termine più appropriato). Qui il terreno comune non era più solo dato da forme mentali comuni ma costruito da una “cultura” fatta di convenzioni, norme ed istituzioni, tessuta da interrelazioni pienamente linguistiche, la logica mentale comune diventava comune razionalità, il soggettivismo prospettico (basato su diversi punti di vista) diventava oggettivo (da tutti i punti di vista). Le rappresentazioni diventavano quindi anche convenzionali ed oggettive, le inferenze divennero anche autoriflessive e poggiate su “ragioni”, l’autoregolazione si apriva alle norme di razionalità della cultura d’appartenenza. Lo sviluppo di tutto questo secondo sistema, secondo Tomasello, non ha basi biologiche ma culturali, è cioè “appreso” nell’ontogenesi.
Il punto di partenza di tutto lo sviluppo mentale fu quello dell’intenzionalità individuale, l’attività off line del pensare prima di agire che è di forma superiore al modello stimolo-risposta, istintuale. Questo pensiero già produce schemi, categorie e modelli, adopera l’immaginazione, è in grado di valutare ed auto modificarsi, financo scegliere di non agire di trattenere la risposta allo stimolo, fare analogie, perseguire propri scopi, simulare prove e dedurre dai possibili errori, attribuire cause, auto monitorare il proprio comportamento e quindi distillando esperienza far interagire mentale e reale. Inoltre, è in grado di quantificare, usare strumenti, usare l’operatore inferenziale “se…allora” (molto importante) ed usare la negazione, inferenze causa-effetto ed effetto-causa, abduzioni (inferenza alla migliore spiegazione), sapere di non sapere, Queste sono caratteristiche che abbiamo pienamente in comune con le grandi antropomorfe (scimpanzé, bonobo, gorilla, oranghi) da cui ci separammo evolutivamente circa sei milioni di anni fa. Questa mente non solo è individualmente intenzionale ma riconosce anche l’altrui intenzionalità con cui comunica usando un ristretto numero di gesti o suoni. Ma tali sviluppi, sembrano esser rimasti al servizio del potenziamento individuale, individui sociali ma fondamentalmente competitivi tra loro. Non sbaglierebbero quindi tutti coloro che leggendo il comportamento degli scimpanzé, ravvedono le basi dei nostri più feroci istinti individualisti e competitivi. Sbaglierebbero però a non considerare quali altri strutture mentali si sono formate nella nostra specifica evoluzione, strutture che hanno incapsulato -usandole- queste capacità cognitive, al fine di sviluppare cooperazione inter-individuale prima e collettiva poi. Questi sarebbero sistemi di ordine superiore non in base ad astratti giudizi di antropo-ideologia ma in base al ruolo evolutivo che hanno svolto nel permetterci di diventare “umani” e non più solo “scimmie”, cioè farci pensare diversamente e quindi farci agire diversamente. La nostra stessa esistenza ed affermazione, testimonia del successo dell’innovazione cooperativa che abbiamo apportato all’origine competitiva.
non solo è individualmente intenzionale ma riconosce anche l’altrui intenzionalità con cui comunica usando un ristretto numero di gesti o suoni. Ma tali sviluppi, sembrano esser rimasti al servizio del potenziamento individuale, individui sociali ma fondamentalmente competitivi tra loro. Non sbaglierebbero quindi tutti coloro che leggendo il comportamento degli scimpanzé, ravvedono le basi dei nostri più feroci istinti individualisti e competitivi. Sbaglierebbero però a non considerare quali altri strutture mentali si sono formate nella nostra specifica evoluzione, strutture che hanno incapsulato -usandole- queste capacità cognitive, al fine di sviluppare cooperazione inter-individuale prima e collettiva poi. Questi sarebbero sistemi di ordine superiore non in base ad astratti giudizi di antropo-ideologia ma in base al ruolo evolutivo che hanno svolto nel permetterci di diventare “umani” e non più solo “scimmie”, cioè farci pensare diversamente e quindi farci agire diversamente. La nostra stessa esistenza ed affermazione, testimonia del successo dell’innovazione cooperativa che abbiamo apportato all’origine competitiva.
Questo primo salto nell’umano si ebbe, secondo Tomasello, creando cooperative di individui. Nel concetto cooperativo, gli individui svilupparono l’attitudine a congiungere le proprie individuali intenzionalità. Scopi congiunti, attenzione congiunta, coordinamento attraverso una più ampia gestualità comunicativa. Opportunamente, Tomasello rileva che i dilemmi sociali della Teoria dei giochi danno per assunto il contesto in cui scopi e preferenze degli individui siano conflittuali mentre quelli del contesto cooperativo, scopi e preferenze sono coincidenti. Il problema nell’utilizzo della Teoria dei giochi quindi, non è nella sua grammatica ma nel presupposto infondato essa definisca gli unici, possibili, assetti delle relazioni umane[2]. Più indietro andiamo nel tempo evolutivo della nostra specie, lì dove vennero a formarsi le nostre strutture interne fondamentali, meno si può fare appello al principio di scarsità che obbliga alla competizione. Semmai il problema era trovare il modo di cooperare per passare dalla caccia alla lepre, alla ben più remunerativa caccia al cervo che in sé, era del tutto preclusa ai singoli individui. Si trattò più di una  scalata ad una sempre maggior abbondanza o sicurezza alimentare quindi, non un girone infernale hobbesiano di disperata scarsità. La scarsità fu un problema del tutto più recente e sarebbe da considerare quando già si son formati grandi gruppi sociali. Quindi: a) non siamo mai stati disperatamente individualisti ma da subito, cooperativi; b) quando eravamo pochi, in piccoli gruppi, la cooperazione fu al servizio dell’affrontare sfide sempre più impegnative che in quanto individui ci erano precluse; c) quando diventammo tanti (anche grazie al successo della precedente strategia), la semplice cooperativa diventa una complessa società ed è tra società che semmai s’instaura la competizione. Quest’ultima modalità, come da noi precedemente già segnalato, è molto recente (15.000 anni? forse meno?) e non ha quindi alcuna ”base biologica”. Naturalmente rimane in noi la mente delle antropomorfe, con i suoi istinti e modi, ma quella mente in noi è solo una parte allacciata ad altre parti più Homo-specifiche ed in quanto tale, essa stessa è -in parte- modificata.
scalata ad una sempre maggior abbondanza o sicurezza alimentare quindi, non un girone infernale hobbesiano di disperata scarsità. La scarsità fu un problema del tutto più recente e sarebbe da considerare quando già si son formati grandi gruppi sociali. Quindi: a) non siamo mai stati disperatamente individualisti ma da subito, cooperativi; b) quando eravamo pochi, in piccoli gruppi, la cooperazione fu al servizio dell’affrontare sfide sempre più impegnative che in quanto individui ci erano precluse; c) quando diventammo tanti (anche grazie al successo della precedente strategia), la semplice cooperativa diventa una complessa società ed è tra società che semmai s’instaura la competizione. Quest’ultima modalità, come da noi precedemente già segnalato, è molto recente (15.000 anni? forse meno?) e non ha quindi alcuna ”base biologica”. Naturalmente rimane in noi la mente delle antropomorfe, con i suoi istinti e modi, ma quella mente in noi è solo una parte allacciata ad altre parti più Homo-specifiche ed in quanto tale, essa stessa è -in parte- modificata.
La moderna teoria economica e socio-politica liberale, farebbe quindi una inversione confusiva terribile perché non direbbe nulla della competizione tra gruppi e società (ed infatti non legge le classi, i gruppi sociali, gli stati e le civiltà ma solo individui) che è la vera competizione esistente mentre cerca di convincerci del fatto che siamo monadi egoiste impazzite appena più furbe (non necessariamente “intelligenti”) degli scimpanzé quando invece tutta la nostra struttura mentale è stata selezionata per incapsulare lo scimpanzé individualista dentro l’umano cooperativo e che è solo per questa ragione, ragione che portò al nostro “successo”, che oggi ci sono pensatori in grado di pensare teorie economiche e socio-politiche, per altro sbagliate.
Vediamo meglio questo primo sistema, il sistema cooperativo. Questo è una evoluzione del sistema delle antropomorfe (leoni, lupi, zoologia prediletta dai narratori liberali) che è comportamento di gruppo in modalità privata. I primi cacciatori raccoglitori (i primissimi erano forse più raccoglitori e pulitori di carcasse, onnivori ma a dieta prevalente vegetale), invece, agiscono coordinandosi in gruppo, riportano il bottino all’accampamento e lo dividono tra tutti. Per tutto ciò, gli individui si aiutano, si cambiano informazioni e si trasmettono capacità, prendono decisioni precedenti l’azione in comune. La nostra progressione del volume cerebrale[3], è stata messa in relazione proprio allo sviluppo dei sistemi mentali cooperativi e sociali. La parte procedurale di molta parte della nostra intelligenza è di natura primate, lo sviluppo di complessità mentale si sarebbe avuto per tridimensionalizzare le nostre capacità al fine di infilarci nella testa, anche le teste degli altri, le interrelazioni, le capacità linguistiche, gli  schemi i modelli e le categorie di questo nuovo mondo dentro di noi adatto a farci agire in quello fuori di noi, fatto di altri come noi, assieme a loro. Lo stigma sociale verso imbroglioni e scansafatiche deriverebbe da questa antica necessità di doversi fidare dell’altro e contare sul suo attivo apporto a risolvere i problemi comuni e questo, poiché la pressione selettiva ci aveva portato a formare gruppi fatti di interdipendenti. Oggi, siamo alla svolta storica per la quale l’interdipendenza sta per presentarsi come imperativo anche per i gruppi a cui abbiamo dato vita. Vale per le classi e vale per gli stati-nazione e le civiltà, ma questo è un altro discorso. Non possiamo qui riportare i passaggi specifici dell’argomentazione di Tomasello che entra molto nel tecnico delle strutture e dei moduli cognitivi del pensiero relazionale ed intersoggettivo che porta all’intenzionalità congiunta, il lettore li troverà nel terzo capitolo del libro. Diciamo solo che le evidenze empiriche delle tesi esposte, stanno negli esprimenti con bambini piccoli che mostrano con chiarezza le differenze cognitive tra umani ed antropomorfe e che queste attitudini allo scambio di informazioni ed indicazioni per coordinarsi (gesti, suoni ed intonazioni e la mimica che è precursore di ogni simbolismo) sono il primo fondamentale passo della nostra speciazione. Questi “modi” anticipano anche il successivo sviluppo di un’altra grande facoltà: l’immaginazione), sono i precursori del linguaggio che quindi fu solo una evoluzione della portanza e qualità espressiva. Questi modi collegati in sequenze, inaugurarono l’espressione proposizionale Da qui anche la nozione di fiducia nella verità che è pre-condizione per tali scambi (di vitale importanza). La menzogna, nota opportunamente Tomasello, funziona solo come eccezione a questa convenzione di verità e fiducia che è intesa come paradigma a governo universale delle interrelazioni umane. Così notò la Arendt (Sulla rivoluzione, 1963. p.111), l’ipocrisia è vizio dei vizi, appena un gradino sotto il male radicale. Questa linea può portare allo sviluppo di un discorso sulla umana ragion pratica naturale (morale-etica) che è infatti l’ultimo libro di Tomasello, non ancora uscito in Italia.
schemi i modelli e le categorie di questo nuovo mondo dentro di noi adatto a farci agire in quello fuori di noi, fatto di altri come noi, assieme a loro. Lo stigma sociale verso imbroglioni e scansafatiche deriverebbe da questa antica necessità di doversi fidare dell’altro e contare sul suo attivo apporto a risolvere i problemi comuni e questo, poiché la pressione selettiva ci aveva portato a formare gruppi fatti di interdipendenti. Oggi, siamo alla svolta storica per la quale l’interdipendenza sta per presentarsi come imperativo anche per i gruppi a cui abbiamo dato vita. Vale per le classi e vale per gli stati-nazione e le civiltà, ma questo è un altro discorso. Non possiamo qui riportare i passaggi specifici dell’argomentazione di Tomasello che entra molto nel tecnico delle strutture e dei moduli cognitivi del pensiero relazionale ed intersoggettivo che porta all’intenzionalità congiunta, il lettore li troverà nel terzo capitolo del libro. Diciamo solo che le evidenze empiriche delle tesi esposte, stanno negli esprimenti con bambini piccoli che mostrano con chiarezza le differenze cognitive tra umani ed antropomorfe e che queste attitudini allo scambio di informazioni ed indicazioni per coordinarsi (gesti, suoni ed intonazioni e la mimica che è precursore di ogni simbolismo) sono il primo fondamentale passo della nostra speciazione. Questi “modi” anticipano anche il successivo sviluppo di un’altra grande facoltà: l’immaginazione), sono i precursori del linguaggio che quindi fu solo una evoluzione della portanza e qualità espressiva. Questi modi collegati in sequenze, inaugurarono l’espressione proposizionale Da qui anche la nozione di fiducia nella verità che è pre-condizione per tali scambi (di vitale importanza). La menzogna, nota opportunamente Tomasello, funziona solo come eccezione a questa convenzione di verità e fiducia che è intesa come paradigma a governo universale delle interrelazioni umane. Così notò la Arendt (Sulla rivoluzione, 1963. p.111), l’ipocrisia è vizio dei vizi, appena un gradino sotto il male radicale. Questa linea può portare allo sviluppo di un discorso sulla umana ragion pratica naturale (morale-etica) che è infatti l’ultimo libro di Tomasello, non ancora uscito in Italia.
Arriviamo così al secondo sistema o stadio umano, quello dell’intenzionalità non più solo condivisa ma congiunta, collettiva, l’intenzionalità del noi. Qui siamo a gruppi di una certa dimensione e le dimensioni contano. Spesso seguiamo discorsi economici o geopolitici o storici di entità comparate azzerando la loro condizione fisica di cui la dimensione e la localizzazione e la storia sono le principali coordinate. Per i gruppi umani questo prende le forme della demografia e della geo-storia. Quando la demografia dei gruppi umani superò una certa dimensione, questi divennero sempre più stanziali e cominciò la trasmissione diacronica delle abilità e conoscenze, cioè la cultura. Quanto prima detto a proposito delle interrelazioni individuali divenne “convenzione”, un pacchetto di strumenti cognitivi, preferenze, credenze, modi. Questa “mentalità in comune” ospitava nuove importanti  conquiste: l’oggettività (il valido per tutti, da tutti i punti di vista), la razionalità (il supportato da ragioni da tutti riconosciute come valide), i processi di autoregolazione normativa validi per tutti, il processo di incremento cumulativo delle dimensioni ed affinamenti dei tratti culturali poi diventata “tradizione”. Questa diventava la cultura di quel gruppo ed ogni gruppo cominciò a creare la propria. Questo iniziò con il sapiens sapiens, quindi da dopo dei 200.000 af e portò altre due novità: a) gli individui dovevano a questo punto adattarsi al gruppo visto che era il gruppo ad adattarsi alla natura; b) i gruppi dovevano adattarsi tra loro. Il primo punto prende le forme del conformismo sociale (inteso nel senso di con-formarsi, formarsi assieme), il secondo prende le forme della competizione tra gruppi[4]. Noi oggi siamo giunti ad un nuovo scalino evolutivo, quello in cui questo secondo punto dovrebbe portarci ad una nuova evoluzione, quella per la quale i gruppi umani (nel nostro caso gli stati, le civiltà, le culture) dovrebbero imparare a convivere poiché non c’è più abbastanza spazio, risorse e possibilità di regolare l’interrelazione tra gruppi, competendo.
conquiste: l’oggettività (il valido per tutti, da tutti i punti di vista), la razionalità (il supportato da ragioni da tutti riconosciute come valide), i processi di autoregolazione normativa validi per tutti, il processo di incremento cumulativo delle dimensioni ed affinamenti dei tratti culturali poi diventata “tradizione”. Questa diventava la cultura di quel gruppo ed ogni gruppo cominciò a creare la propria. Questo iniziò con il sapiens sapiens, quindi da dopo dei 200.000 af e portò altre due novità: a) gli individui dovevano a questo punto adattarsi al gruppo visto che era il gruppo ad adattarsi alla natura; b) i gruppi dovevano adattarsi tra loro. Il primo punto prende le forme del conformismo sociale (inteso nel senso di con-formarsi, formarsi assieme), il secondo prende le forme della competizione tra gruppi[4]. Noi oggi siamo giunti ad un nuovo scalino evolutivo, quello in cui questo secondo punto dovrebbe portarci ad una nuova evoluzione, quella per la quale i gruppi umani (nel nostro caso gli stati, le civiltà, le culture) dovrebbero imparare a convivere poiché non c’è più abbastanza spazio, risorse e possibilità di regolare l’interrelazione tra gruppi, competendo.
Ogni gruppo prese quindi a sviluppare e trasmettersi internamente la propria cultura ed ogni individuo inidoneo alla gruppalità venne ostracizzato come sappiamo ancora in uso nell’Antica Grecia. Tomasello nota opportunamente che la teoria del “contratto sociale” in realtà presuppone proprio ciò che dovrebbe spiegare. Noi non siamo mai stati individui l’un contro l’altro armati che poi “ragionevolmente” hanno trovato un accordo (contratto) per sopportarsi nella comune convivenza (sociale), non avremmo avuto tra l’altro né una  mentalità, né modi di esprimerla (linguaggio) comuni per discutere di questo accordo. La nostra socialità è primitiva, la società fu la conseguenza dell’incremento demografico, l’istituzionalizzazione fu la conseguenza del venire a formarsi di una mentalità e di una serie di pratiche condivise e trasmissibili. Colpa, vergogna, stigma sociale, conformismo introiettato e proiettato su gli altri in quanto giudizio, capacità di argomentare secondo (comune) ragione, ansia di accettazione, riconoscimento sociale, ricerca della altrui benevolenza, reputazione, status, potere, simbologia della posizione sociale, regolamenti di convivenza, convenzioni sociali basate su dati concreti o anche sul “tutti facciamo finta che…”, giustizia, discorso pubblico, rete olistica delle credenze, modi di pensare-dire-fare-giudicare “tradizionali”, decisionalità condivisa e riconosciuta e naturalmente il linguaggio, la logica ed i loro prodotti tra cui i concetti, sono tutti portati di questo sistema di intenzionalità condivisa che è la società umana. Questo è quello che nei nostri scritti spesso chiamiamo “immagine di mondo”.
mentalità, né modi di esprimerla (linguaggio) comuni per discutere di questo accordo. La nostra socialità è primitiva, la società fu la conseguenza dell’incremento demografico, l’istituzionalizzazione fu la conseguenza del venire a formarsi di una mentalità e di una serie di pratiche condivise e trasmissibili. Colpa, vergogna, stigma sociale, conformismo introiettato e proiettato su gli altri in quanto giudizio, capacità di argomentare secondo (comune) ragione, ansia di accettazione, riconoscimento sociale, ricerca della altrui benevolenza, reputazione, status, potere, simbologia della posizione sociale, regolamenti di convivenza, convenzioni sociali basate su dati concreti o anche sul “tutti facciamo finta che…”, giustizia, discorso pubblico, rete olistica delle credenze, modi di pensare-dire-fare-giudicare “tradizionali”, decisionalità condivisa e riconosciuta e naturalmente il linguaggio, la logica ed i loro prodotti tra cui i concetti, sono tutti portati di questo sistema di intenzionalità condivisa che è la società umana. Questo è quello che nei nostri scritti spesso chiamiamo “immagine di mondo”.
Dalla capacità ed abitudine ad esternare e condividere con altri pensiero complesso, deriva anche la facoltà di riflessione cioè di pensare il proprio pensiero, ciò che Aristotele chiamava “dio” ed Hegel poneva in cima la processo di sviluppo dello Spirito, alla fine della sua Enciclopedia. Il “logos” non sarebbe quindi una facoltà primigenia individuale ma deriverebbe dalla trattativa su un logos comune, un logos tra due, il dia-logos, il dialogo. Si noti la testarda asimmetria dei fondamenti della cultura occidentale ed in specie della sua fondazione platonica. Ogni essere è frutto di una relazione in natura ma nel nostro pensiero ci siamo convinti sia la discendenza da un Uno, ogni verità è frutto di una convenzione tra due (o più) ma ci siamo convinti sia solo il pallido riflesso di una verità in sé. L’Uno Vero in sé è il Bene per Platone mentre pare che sia il Molteplice Relativo lo statuto ontologico del nostro essere sociale. Siamo noi che stabiliamo il reale, il vero ed il giusto e se la smettessimo di pensare che esista nelle forme del Reale, Vero e Giusto (cioè dell’Assoluto) forse impareremo a stabilirlo democraticamente con coscienza sociale invece di farcelo imporre da qualcuno più abile e furbo di noi. Infine, questa costruzione della cultura comune ha sempre radici geografiche (di quel gruppo e non di quell’altro) e storiche (di quel periodo e non di quell’altro). Questo secondo passaggio fu quindi prendere il pensiero cooperativo e prospettico dei primi Homo e collettivizzarlo dandogli il crisma da tutti riconosciuto dell’oggettività, del valido per tutti, per convenzione. Il pensiero collettivo, oggettivo, riflessivo, normativo, cioè “umano” nel senso proprio.
essere è frutto di una relazione in natura ma nel nostro pensiero ci siamo convinti sia la discendenza da un Uno, ogni verità è frutto di una convenzione tra due (o più) ma ci siamo convinti sia solo il pallido riflesso di una verità in sé. L’Uno Vero in sé è il Bene per Platone mentre pare che sia il Molteplice Relativo lo statuto ontologico del nostro essere sociale. Siamo noi che stabiliamo il reale, il vero ed il giusto e se la smettessimo di pensare che esista nelle forme del Reale, Vero e Giusto (cioè dell’Assoluto) forse impareremo a stabilirlo democraticamente con coscienza sociale invece di farcelo imporre da qualcuno più abile e furbo di noi. Infine, questa costruzione della cultura comune ha sempre radici geografiche (di quel gruppo e non di quell’altro) e storiche (di quel periodo e non di quell’altro). Questo secondo passaggio fu quindi prendere il pensiero cooperativo e prospettico dei primi Homo e collettivizzarlo dandogli il crisma da tutti riconosciuto dell’oggettività, del valido per tutti, per convenzione. Il pensiero collettivo, oggettivo, riflessivo, normativo, cioè “umano” nel senso proprio.
Insomma, Cartesio l’avrebbe fatta un po’ troppo semplice, in realtà la sequenza avrebbe dovuto essere: 1) in quanto stimolato dal mio intorno sociale; 2) penso riflessivamente: 3) e quindi so di essere. E l’avrebbe fatta troppo semplice anche Hobbes in quanto per fare un contratto di  società ci vogliono tutta una serie di cose che si hanno solo se c’è già una storia di convivenza ed azione collettiva, una società. Così gli innatisti (tutti di discendenza platonica) in quanto le facoltà di possibilità sono ereditate ed a priori ma provenendo da una storia collettiva e soprattutto, non si attivano se non quando si esprimono per ciò per cui si sono fissate nella nostra filogenesi, non si esprimono se non in un certo tipo di ontogenesi che com’è noto, per la nostra specie, è in assoluto la più lunga del regno animale (la nostra “lunga” infanzia”). Un po’ quello che noi abbiamo altrove definito “essere una relazione”[5]. La società proviene da una mente sociale e la mente sociale proviene da una storia sociale che inizialmente ebbe un primo scarto rispetto alle antropomorfe dove comparì il primo set che ci portò alla condivisione, condivisione che ci permise di vincere la nostra prima partita adattiva dandoci la possibilità di diventare quello che oggi siamo.
società ci vogliono tutta una serie di cose che si hanno solo se c’è già una storia di convivenza ed azione collettiva, una società. Così gli innatisti (tutti di discendenza platonica) in quanto le facoltà di possibilità sono ereditate ed a priori ma provenendo da una storia collettiva e soprattutto, non si attivano se non quando si esprimono per ciò per cui si sono fissate nella nostra filogenesi, non si esprimono se non in un certo tipo di ontogenesi che com’è noto, per la nostra specie, è in assoluto la più lunga del regno animale (la nostra “lunga” infanzia”). Un po’ quello che noi abbiamo altrove definito “essere una relazione”[5]. La società proviene da una mente sociale e la mente sociale proviene da una storia sociale che inizialmente ebbe un primo scarto rispetto alle antropomorfe dove comparì il primo set che ci portò alla condivisione, condivisione che ci permise di vincere la nostra prima partita adattiva dandoci la possibilità di diventare quello che oggi siamo.
Alla fine, l’aveva vista giusta Aristotele. L’uomo è animale politico nella misura in cui è proprio di una città-stato, cioè di una comunità ed è razionale o ragionante nella misura in cui usa questa mente ed il supporto linguistico per interrelarsi e cooperare con gli altri. Se questo è lo stato politico o sociale, lo stato di natura, per gli uomini, fu comunque non individuale, formato attorno alla famiglia nucleare[6] o forse più d’una di modo da avere chi curava la prole e chi andava a caccia e raccolta[7], basato sull’interrelazione, la cooperazione e la condivisione. Meno Hobbes, più Kropotkin[8].
= 0 =
In conclusione, il nostro specifico è mentale e questo mentale è vocativamente relazionale. Quando i numeri della demografia dei gruppi sono cresciuti, questo impianto è salito di grado in una spirale di aumento della complessità mentale e di quella sociale. Oggi siamo ad un nuovo salto in avanti. Di nuovo i numeri della demografia, ma non quelli dei gruppi ma dell’umanità tutta, ci portano ad un pianeta tutto pieno. Siamo spinti gli uni verso gli altri ma la nostra mentalità è ancora quella che ha dato vita a società separate e l’un con l’altra, in competizione. Ma competizione tra stati e civiltà, data la demografia generale, le risorse e i chilometri quadrati vivibili della superficie terrestre, porta ad un fallimento adattivo generale, ad un lose-lose. Per salire di una altro grado e trovare l’adattamento interno al sistema generale del tutto pieno occorrerà ristrutturare a fondo le nostre società, le nostre culture, le nostre credenze, i nostri modi sociali, economici e politici. Dovremmo tornare a cooperare, non solo tra individui ma tra gruppi. tra società, tra stati. Per farlo, occorrerà sviluppare una mente di diversa complessità ed è a questo compito che è dedicato il nostro impegno.
ad un nuovo salto in avanti. Di nuovo i numeri della demografia, ma non quelli dei gruppi ma dell’umanità tutta, ci portano ad un pianeta tutto pieno. Siamo spinti gli uni verso gli altri ma la nostra mentalità è ancora quella che ha dato vita a società separate e l’un con l’altra, in competizione. Ma competizione tra stati e civiltà, data la demografia generale, le risorse e i chilometri quadrati vivibili della superficie terrestre, porta ad un fallimento adattivo generale, ad un lose-lose. Per salire di una altro grado e trovare l’adattamento interno al sistema generale del tutto pieno occorrerà ristrutturare a fondo le nostre società, le nostre culture, le nostre credenze, i nostri modi sociali, economici e politici. Dovremmo tornare a cooperare, non solo tra individui ma tra gruppi. tra società, tra stati. Per farlo, occorrerà sviluppare una mente di diversa complessità ed è a questo compito che è dedicato il nostro impegno.
= = =
[1] La cooperazione è diversa dalla semplice socialità, né vale –ovviamente- l’analogia con gli insetti eusociali ( si veda E. O. Wilson)
[2] La moderna Teoria dei giochi è sorta (J. Von Neumann, O. Morgenstern, 1944) in ambito matematico-economico ma è risultata molto applicata nelle strategie della guerra fredda. E’ stata cioè usata sia per comportamenti individuali che collettivi, nelle relazioni sempre di tipo competitivo. Tomasello ci dice che quelle tra gruppi, collettivi e stati sono effettivamente competitive ma quelle tra individui sono antropo-geneticamente cooperative.
[3] Dunbar, R., The social brain hypotesis, in “Evolutionary Antropology” 6, pp.178-190
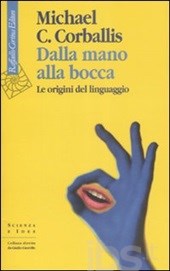 [4] Abbiamo anche in precedenza espresso qualche riserva su questa spiegazione attraverso la pressione competitiva. Per ragioni di densità abitativa, è molto improbabile che vi siano state pressioni competitive territoriali almeno fino a tempi relativamente recenti. In termini di sistemi, non è affatto necessario che vi sia una pressione competitiva con altri gruppi perché si rinforzino le strutture dell’autorganizzazione sistemica.
[4] Abbiamo anche in precedenza espresso qualche riserva su questa spiegazione attraverso la pressione competitiva. Per ragioni di densità abitativa, è molto improbabile che vi siano state pressioni competitive territoriali almeno fino a tempi relativamente recenti. In termini di sistemi, non è affatto necessario che vi sia una pressione competitiva con altri gruppi perché si rinforzino le strutture dell’autorganizzazione sistemica.
[5] https://pierluigifagan.wordpress.com/2014/02/18/essere-una-relazione/
[6] Chapais, B., Primeval Kinship, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2008
[7] Hrdy, S., Mothers and Others, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2009. Nella bande di cacciatori – raccoglitori, probabilmente i due ruoli non erano coincidenti coi sessi nel senso che la raccolta era attività forse presentemente femminile ma più probabilmente mista. La cura dei bambini era forse esercitata a rotazione in una sorta di asilo di comunità da una o più donne a turno, almeno fino a quando non si cominciò a vivere di più e comparvero le nonne.
[8] P. A. Kropotkin, Il mutuo appoggio, 1902
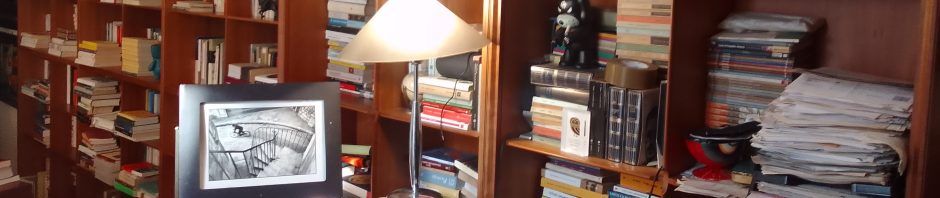





L’ha ribloggato su POLITICHE SOCIALI e SERVIZI:.
Grazie
E RILANCIATO IN QUESTO GRUPPO DI DOCUMENTAZIONE: https://www.facebook.com/groups/ferrariopolser/
Vedo, grazie per la considerazione ed in bocca al lupo per il suo impegno alla divulgazione di un certo punto di vista che, vedo, fa parte del suo background.
sì, molto back: sono del 1948. saluti e buon futuro